| La stanza di Andrea Amedeo Sammartano |
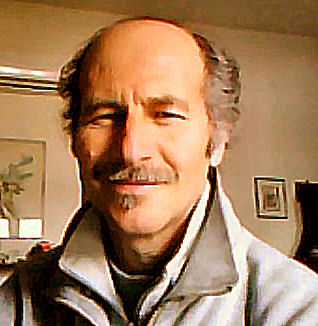 |
| Andrea Amedeo Sammmartano |
|
CHIUDO
GLI
OCCHI
DUE
SECONDI, di Andrea
Sammartano |
ccc
|
Capitolo 14
GLI ATTENTATI
I cani potranno anche festeggiare sui cadaveri dei leoni, ma i cani restano cani e i leoni restano leoni (Muammar al Gheddafi)
Come premessa vorrei precisare che l’Italia, con cui la Libia intratteneva rapporti privilegiati per miliardi di dollari con aziende quali Fiat, Snam, Eni, Agusta, solo per citare le più note, è stato il Paese dove si concentrava il più alto numero di ricchi miei conterranei fuoriusciti. A costoro, in barba
agli accordi internazionali,
era
garantita una indecente immunità ed era consentito di complottare
spudoratamente non solo contro le nostre istituzioni, ma anche contro
le nostre vite. Mi ha offeso l’opportunismo politico emerso in
alcune circostanze del passato e anche di recente. Del passato voglio solo ricordare
la
reticenza del
governo italiano
quando un attentato di probabile
matrice
francese, mancando
un aereo
libico sul quale presumevano la mia presenza, provocò la caduta del DC9 della compagnia
Itavia nel cielo di
Ustica.
Da possibile vittima fui accusato di essere il mandante. Se non bastasse questo, vi informo che per non permettere alla verità di risalire a galla, numerose altre vittime civili e militari, assistenti di volo e addetti ai radar, testimoni dell’accaduto, scomparvero in circostanze sospette. Di recente, l’intervento dell’aviazione italiana nel 2011, al fianco della illegale coalizione NATO nei bombardamenti quotidiani durati sette settimane, ha provocato morti tra i civili facendo a pezzi quel senso di lealtà sbandierato alla firma dell’accordo di amicizia, partenariato e cooperazione nell’agosto del 2008. Coinvolti in una politica di subalternità adottata fin dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia ha sganciato migliaia di bombe sui propri interessi economici. Se fossi un titolare di impresa o anche solo uno delle migliaia di lavoratori danneggiati dalla succube politica estera italiana, riverserei la mia ira sui responsabili fino a ottenerne la destituzione e la messa in stato di accusa per palesi omissioni nella cura degli interessi primari della nazione. Gli unici bilanci difesi da questi presunti esportatori di pace sono quelli delle fabbriche di armi direttamente connesse ai propri tornaconti personali. Già nel 1970 non sopportavo e non potevo permettere che il pericolo per la Libia fosse costituito da miei connazionali fuggiti con borse colme di denaro e salvaguardati da una nazione considerata “amica”, proprio alle soglie di casa. Ne parlai in anticipo con i servizi segreti, ed erano argomenti, mi dissero, impraticabili alla luce del giorno, nelle normali relazioni diplomatiche. Il Governo italiano, mi informavano sempre le stesse fonti, non sarebbe potuto intervenire, ma una parte dei servizi ci assicurava carta bianca su eventuali operazioni volte alla difesa dell’integrità territoriale libica e della vita delle sue autorità. Una soluzione come sempre poco chiara e soggetta a smentita ufficiale in qualsiasi momento. Non si erano ancora spenti gli echi del miserabile tentativo messo in atto dal “principe nero” Abdallah Abed al Senussi, nipote del re Idris, per riportare la monarchia nel Paese con un’invasione dai confini fezzanesi, quando fui messo al corrente del complotto in cui era coinvolto Omar Shalhi, che aveva base in Italia. E sempre dall’Italia si tiravano le file degli attentati che uno dopo l’altro si susseguivano. Dopo aver catturato i mercenari del principe nero e i suoi complici libici, tra cui la famiglia Seif al Nasr, ex ufficiali dell’esercito, imprenditori e faccendieri del vecchio regime, condannammo tutti a lunghe pene detentive, evitando la sentenza capitale come previsto invece dalla legge. Eravamo ancora convinti che non avremmo avuto nulla da guadagnare nell’imporre con la forza una concordia nazionale artificiosa, rinnegabile alla prima occasione. Per un lungo periodo sono riuscito a tenere salde le briglie di ogni moto istintivo di vendetta, una reazione moderata avrebbe meglio rappresentato le mie intenzioni razionali. Mi chiedevo però per quanto tempo ci sarei riuscito. Ai nostri occhi erano così palesemente patriottici gli intenti della nostra Rivoluzione e così chiaramente smascherato il profilo corrotto del regime monarchico, che nessun alibi poteva essere concesso a un qualunque tentativo controrivoluzionario di quella matrice. Chiunque di loro si fosse attivato, lo avrebbe fatto con credenziali inattendibili e solo con la forza avrebbe potuto soggiogare di nuovo un popolo al quale avevamo aperto gli occhi. Una constatazione inaspriva i miei sentimenti nei confronti dei traditori mentre rafforzava il mio orgoglio: dalle sedi dei congressi e dei comitati popolari mi riferivano della gioia diffusa tra la gente e io, non pago, per una sorta di incredulo piacere, mi infiltravo inosservato nelle strade, nei mercati e nei caffè da un capo all’altro della nazione. Ascoltavo le voci finalmente allegre degli esclusi al tempo del re, rubavo i loro pensieri per custodirli geloso o catturavo sui visi la muta meraviglia per il riscatto al quale li avevo indirizzati. Guai a chi avesse deturpato queste immagini, simbolo della prima concretezza in cui si avvolgeva una speranza. In quel periodo imparai a essere sincero con la mia gente e incomprensibile con gli interlocutori esteri tanto quanto essi lo erano con me. Agli esordi, gli Stati Uniti, nonostante la perdita della base aerea di Wheelus Field, mi adulavano inviandomi, attraverso la CIA o il fido alleato italiano, dettagli determinanti sulle congiure in corso ai miei danni. Che cosa li induceva a spingersi oltre ogni logica? Nient’altro che una logica più redditizia: l’interesse per il nostro potenziale petrolifero e il compiacimento per l’iniziale dichiarato anticomunismo. Fin quando tale strategia avesse rispettato una reciproca autonomia non avremmo avuto da parte nostra motivo di combatterla. Ma a lungo termine essi non tollerarono le nostre istanze di indipendenza universale, quanto non sopportavano l’avversione per il capitalismo che ci portò, con l’Africa unita alle spalle, alla contrapposizione economica accennata prima. L’Inghilterra invece, la cui base aerea
di El
Adem era stata smantellata al pari di
quella
statunitense, complottava al coperto con i dissidenti riparati
all’estero.
Cosciente dell’inesorabile declino coloniale al quale era andata incontro, ma determinata a preservare con nuove strategie quanto rimaneva del passato splendore, sferrava gli ultimi colpi di coda. In combutta con qualche avventuriero tentava il recupero del banco perduto. Un caso emblematico tra questi, l’unico che citerò per non scadere nell’arida cronaca, fu il proposito di Omar Shalhi, plenipotenziario alla corte di re Idris al Senussi e da sempre fedele suddito di una qualche maestà, come quella britannica in questo frangente. Si era rifugiato in Svizzera, paradiso dei più loschi evasori e trafficanti finanziari di ogni tempo. Dalla lussuosa villa-fortezza nei sobborghi di Ginevra non aveva intenzione di mollare l’osso già abbondantemente spolpato. Nel breve volgere di un anno e mezzo dalla Rivoluzione, con una spesa superiore al milione di dollari pianificò ben quattro tentativi controrivoluzionari che consideravano anche l’opzione della mia eliminazione fisica. Avevo messo in conto ipotesi simili, ma non avrei immaginato tanta protervia e ostinazione. Purtroppo l’accanimento dell’opposizione riparata all’estero e dei loro alleati spense la residua speranza di pacificazione nazionale: a prevalere su ogni altra considerazione era la necessità di difendersi, e non certo in modo passivo. Non voglio indurre
alla noia e tanto meno alla commiserazione accennando alla
serie
infinita di
attentati, con i quali credo di aver stabilito, senza
troppovantarmene, un primato. Vorrei
solo domandare alle menti più suggestionabili, che non rischiavano il piombo quanto
me, se il
diritto alla legittima difesa fosse ammesso anche nel mio caso. Se
tale diritto
non fosse stato di per sé sufficiente a giustificare le
mie
reazioni ne aggiungo un altro, sul quale nessun libico, al di fuori
della mia persona, poteva al momento rivendicare un credito maggiore:
quello di
provare a governare la nazione con la dedizione che derivava dalle privazioni, dai rischi e
dalle
sofferenze spirituali sopportati da
anni per
arrivare alla
meta. Ero cosciente che nessun altro individuo quanto me amasse la Libia al pari della causa
panaraba. Sapevo
perfettamente
quanto fossi disposto ad
annullarmi pur di mettere a disposizione del rais Gamal Abd el Nasser
la nostra ricchezza spirituale
e materiale. Avrei potuto
commettere solo un unico
errore: non
provarci. Abdessalam Jalloud fu l’unico a condividere questa strategia fino all’esasperazione, in particolare quando era l’ora di affrontare i nemici. In seguito, tra di noi, rivelava tutta la sua maestria canzonando e descrivendo le reazioni disorientate degli interlocutori ai nostri improvvisi cambiamenti di spirito: le smorfie incontrollate degli ambasciatori ai programmati moti di nervosismo scoprivano la loro scarsa fermezza; lo stupore allo sfoggio nelle sedi istituzionali dei costumi tradizionali libici denotava l’insensibilità generale a una appartenenza ben identificata.
Necessitavo tuttavia di un filtro, una sorta di sbarramento trasparente costituito dai collaboratori più fidati da interporre tra me e gli innumerevoli fronti davanti ai quali ero chiamato a resistere. Ambivo a non perdere di vista la generalità del patrimonio conseguito ma non mi esonerai mai dal deciderne le priorità esecutive. Non amavo occuparmi dei dettagli amministrativi perché frenavano la realizzazione dei progetti più urgenti e questo scopriva un elemento inequivocabile di me: la mia inesperienza e la scarsa passione in quelle pratiche. Affidai questo compito non senza apprensione alle mani di esperti. Nonostante ciò, l’incessante susseguirsi dei complotti inasprì la mia persona, e per reazione cominciò ad affiorare nel mio atteggiamento un tratto mai prima conosciuto: l’incapacità di perdonare. Divenni inflessibile e con il passare del tempo immune all’indulgenza, ma non per pura superbia, semmai per una convinzione: se ero divenuto il prescelto nell’impresa a cui Dio aveva destinato la Libia, egli stesso sarebbe stato chiaro e tempestivo mediante un segnale in caso di errore. Dal giorno successivo alla Rivoluzione fino a oggi ho affinato la tecnica per interpretare ogni indistinta avvisaglia e per reagire alle conseguenze di ogni evento negativo di cui avevo sentore e nulla più. Mi persuasi altrettanto, per l’insufficiente rigore ideologico dimostrato dagli altri componenti del Consiglio del Comando rivoluzionario, eccezion fatta per Jalloud e per qualche altro elemento, che non potevo perdere di vista la guida dei settori più delicati per quanto riguarda la difesa dello Stato. Rinforzai gli apparati di sicurezza e, stanco di subire assalti in piena passività, autorizzai i comitati rivoluzionari a compiere operazioni preventive sia all’interno che all’estero. A poco a poco cominciai a delegare all’etica di un gruppo di volenterosi alcune mansioni di rilievo, espropriandole dalle mani e dalla debolezza di un solo responsabile, anche dalle mie. In ogni occasione raccomandai che bisognava dare precedenza alla prevenzione rispetto alla repressione e, come mi aspettavo, forti della garanzia di una decisione condivisa, il gruppo che si era assunto alcune delle funzioni amministrative via via ridusse gli spazi dove si aggiravano biechi gli oppositori interni, sia in patria che all’estero. Non era più possibile dedicarsi ai propri compiti sotto la minaccia di una risibile minoranza. Comunque, se l’immane impegno psicofisico era fonte di pensieri per i miei cari e per i medici, non lo era per me. In alternativa ai farmaci, sapevo come resistere a eventi che sembravano schiacciarmi e sul punto di farmi soccombere: tornavo indietro nel tempo e nello spazio, stringendomi forte ai fidati consiglieri dei momenti più incerti. Erano gli anziani l’unico punto saldo: mio padre o il vecchio insegnante di Corano di Qasr Abu Hadi fin quando rimasero in vita, ma anche i parenti e gli attempati abitudinari incontrati durante le passeggiate giovanili al villaggio o a Sirte. Erano loro a rappresentare lo sprone, anzi, non esitavano franchi ma proficui ammonimenti quando si stringevano a me. L’atteggiamento amichevole entro il lieve sorriso sincero con cui mi accoglievano sereni, nonostante la loro salute provata per l’età avanzata, mi incoraggiava a proseguire, a tenerli in giusta considerazione. Mi concedevano la priorità senza curarsi della miriade di angosce e privazioni trascorse per la protervia dell’invasore coloniale prima e per l’insensibilità di un monarca calcolatore poi. Mi permettevano di sedere al loro fianco, finalmente sotto una tenda. A volte, avvertendo la mia inquietudine, indecifrabile solo agli occhi estranei, mio padre mi prendeva per mano e mi conduceva all’aperto come un tempo, fuori dal turbinio dei dubbi insidiosi, senza azzardare una soluzione, ma di certo nell’unico posto al riparo da ogni possibile agguato. Mi sarebbe stato più utile trascorrere un’intera stagione in quel luogo, dove la comprensione per l’immane impegno e la consapevolezza del complicato ma anche violento contesto locale e internazionale entro cui mi dibattevo, garantivano, a ogni mio agire, una fraterna benevolenza. Nessuno si avventuri in considerazioni maligne o pensi a una strumentalizzazione, se questo dedicato agli attentati è stato uno degli argomenti rivelati. Qualche giorno fa, mi hanno riferito un dato spaventoso: negli ultimi otto mesi la mia terra è stata violata dagli scarponi di soldati statunitensi, francesi, tedeschi, canadesi e, senza vergogna, da quelli turchi, qatarioti, sauditi, egiziani e sudanesi. Sono state sganciate 17000 bombe, lanciati 2500 missili, sparati 10000 proiettili di artiglieria e 7000 razzi. Ho trascorso sotto assedio la maggior parte del tempo concesso al mio mandato. E sotto assedio lo sono anche in questo momento. Con il passare delle ore, all’interno del condotto in cui mi sono svegliato come da un incubo, sono per la prima volta consapevole di quanto sia sgradevole il timore di non essere più arbitro del mio futuro. Non tanto per la situazione critica in cui mi trovo – a dire la verità me la sono cavata in casi peggiori –, quanto per la sensazione di non poter più determinare la mia vita con la semplice volontà. Ho sempre perseguito una priorità: difendere la sovranità della mia terra, e ora, espropriato del tutto, torno ad apprezzare il valore della scelta che feci. Ripercorro daccapo la mia esistenza, e mettendomi dalla stessa parte di chi potrebbe giudicarmi, tento di scoprirne quei tratti che sono affondati in modo colpevole nella trascuratezza, nell’omissione, nella prevaricazione del prossimo. Mi chiedo se gli insuccessi di cui farei bene a pentirmi vanno colti nell’impeto risoluto, forse disordinato, opposto all’ingiustizia, o nella idealità troppo audace e spregiudicata da cui scaturivano le mie proposte; e anche nel sacrificio imposto al mio popolo per la realizzazione di obiettivi non ancora assimilati nei fini ultimi. Mi sento responsabile nel bene e nel male della sorte alla quale ho indirizzato la vita di uomini e donne che hanno creduto in me; persino gli oppositori che non meritano tale preoccupazione vi sono presenti in modo vago, e in fondo, venire allo scoperto li ha distinti dalla banalità, dalla inutilità dell’esistenza incolore degli unici assenti: gli indolenti. Ora che l’effetto ipnotico provocato dai bombardamenti con gas nervini di cui reputo essere stato vittima si sta dissolvendo, sento di essere circondato. Qualcuno sta per consegnarmi a qualcun altro, e non ci vuole troppo tempo per intuire come andrà a finire. Essere sorpreso come un ratto e catturato in uno scarico potrebbe essere una messa in scena impeccabile da un punto divista simbolico per i miei detrattori. La furbizia strategica dei neocolonialisti intervenuti in questa farsa prevede, dopo gli inusitati bombardamenti, l’umiliante cattura del despota da parte degli stessi confratelli esasperati dalla sua malvagità. Il finale è perfetto per chi se lo aspettava proprio così già da tempo e anche per chi lo assumerà come un placebo solo per far pace con le proprie ossessioni. Io non sarò il primo e nemmeno l’ultimo dei nemici pubblici da eliminare. Se dopo di me non dovessero esserci altri folli verso cui indirizzare la furia fanatica, come in ogni precedente crociata dell’ipocrita “fondamentalismo democratico”, sapranno come fabbricare un nuovo mostro da gettare in pasto ai soliti semplici o troppo furbi benpensanti. I potenti nemici sono alla costante ricerca di un capro espiatorio per affermare la legalità alla luce di una personale quanto disinvolta interpretazione. E riguardo alla legalità, sarebbe così semplice distinguere tra quella presunta, in balia di ogni sfrenato egoismo individuale, e quella, pur imperfetta, tesa a ridurre la sofferenza delle moltitudini. Durante la mia azione ho sempre agito nel tentativo di aggregare i più deboli: arabi, africani o qualunque altro diseredato del mondo. La strategia nemica predica una guerra duratura e votata alla divisione della società civile, laica o religiosa che sia. L’aggregazione o la divisione, ecco la semplice differenza, le due sfumature attraverso le quali leggere la cartina di tornasole che svela il merito della scelta. Quanto ai libici, non mi mancano le forze per indirizzare, almeno un’ultima volta, ogni mia furia alla malvagia furbizia dei pochi traditori. All’ingenuità dei tanti precipitati nelle maglie di una rete sottile e ben visibile solo da chi ne ha a cuore l’indipendenza culturale, politica ed economica, invio il mio biasimo. Ad ambedue, traditori e ingenui, l’ultimo richiamo da fratello maggiore. Anche se molti di voi non sono nati tra la sabbia del deserto, non vi accanite a disconoscere la vera, unica cultura di provenienza a cui fare riferimento fosse anche tra mille anni: quella beduina. Non vi affaticate nei goffi tentativi di mascherarla dietro abiti inospitali, atteggiamenti incerti, abitudini d’importazione o inutili prese di distanza; essa, così fiera e mite, di certo con il tempo affinata, rimarrà indelebile in ciascuno di voi oltre ogni artificiosa esteriorità. Per questo, nonostante i mutamenti accettati o quelli ai quali ho solo fatto finta di adattarmi, mi rendo conto, nello spirito, di essere ancora la stessa creatura: un adolescente vestito di una tunica sgualcita e forse un po’ lacera, che si aggira curioso tra gli infiniti risvolti della propria storia, comune ai coetanei e già vissuta dai più anziani. Qualcuno mi accusa di aver impedito ai libici il piacere di vivere, ma posso essere d’accordo con questa affermazione solo se si riferisce alla vacuità delle attuali euforie e non alla concreta semplicità con cui noi appagavamo, da giovani, le nostre aspirazioni. E non azzardatevi, voi privi di senso critico, ad accettare impunemente il nuovo e neppure ad accusarmi di arretratezza o ignoranza. Io, a differenza di voi, viziati e indeboliti, potrei risparmiare anche sull’“essenziale” offerto dalla nostra terra prima della maledetta scoperta del petrolio, se questo dovesse servire a mantenerla libera da ogni ingerenza indebita. Voi piuttosto, al passo con il pensiero dominante, state solo aspettando l’implosione più o meno prossima di questo meraviglioso pianeta, se non vi accorgete della necessità di compiere un passo indietro. Certo, tengo a bada queste “maledette, benedette” risorse, le sfrutto con par- simonia e, all’avidità dilagante le nascondo anche. La ragione non è l’egoismo, come qualche miope opportunista tenta di insinuare. Renderle durature e non permettere una compromissione della qualità dell’aria, ad esempio, comporta meno introiti a breve scadenza; se mi adeguassi al passo richiesto, alle nuove generazioni rimarrebbero solo gli effetti secondari, già disastrosi oggi. Ho sempre sofferto di una intolleranza respiratoria verso le polveri dell’inqui- namento. Già negli anni Sessanta, quando mi recavo nei Paesi industrializzati, la pesantezza del respiro allertava l’intera mia persona in un tremito ricorrente. Siamo ormai tutti stretti e soffocati all’interno di un’urgenza; ritornare a una vita più semplice non è più rinviabile, perché è in essa che potremmo provare a riordinare quella scala di valori ribaltata dalla politica, dalle ideologie, dall’economia e, perché no, da una folle interpretazione di tutte le religioni. Ai miei sostenitori, quella maggioranza disposta ad accettare anche l’imperfezione che è propria di questo meraviglioso se pur misero ghetto che ci ospita temporaneamente, lascio il piacere di trasmettere ai più cari tra i loro amici e confidenti l’intimità di un’esperienza vissuta entro il limite sensato di ogni frontiera. So di avervi controllato, di aver dato l’impressione di spiarvi, di opprimervi e forse anche di derubarvi, ma in questo momento la nostra nazione è di certo migliorabile, ma da quarantadue anni è libera da ingerenze straniere e, con le risorse risparmiate e i capitali investiti, se protetti, lo sarà ancora più a lungo. Guardando a ritroso la nostra storia, qualcosa di simile era forse mai successo? Se dovesse accadere l’indicibile, conoscendo i cani che si stanno azzannando per strapparmi il potere, saranno presto tangibili le differenze tra me e i miei successori. Anche se non è ancora messo a punto del tutto, offro il mio modello di governo in dono alla maggioranza ingannata e in difesa della quale non sono fuggito, ispirato dal dovere di salvare l’onore e la reputazione della nostra cultura. Dopotutto, Omar al Mukhtar è stato un mio maestro.
Mai come in questo momento, braccato da una alleanza internazionale di spietati finanzieri guerrafondai e dalla peggiore teppaglia libica di esaltatifondamentalisti, mi sono sentito così defraudato. Le scaltre rappresentanze amministrative degli uni e degli altri sono già all’interno dei nostri forzieri dove si trova custodito il futuro della Libia. In essi, non uno dei 150 miliardi di dollari, non un grammo delle 143 tonnellate d’oro che compongono le nostre riserve risulta intestato a mio nome. Le canaglie perdono tempo alla ricerca di qualche elemento che possa provare la mia corruzione. Quando si arrenderanno all’evidenza contraria, non si faranno scrupoli a creare false prove, uniformandosi a una pratica ormai corrente nelle nazioni che non possono concepire l’idea del loro fallimento ideologico ed economico, reso evidente dal nostro successo. Ciò che trovano inaudito e rigettano più di tutto è l’idea che una comunità considerata arretrata come la Libia detenga un tesoro nazionale che nessuna altra economia ha saputo creare, nemmeno quelle che si atteggiano a detentrici del sapere e del potere mondiale. Il tutto in una prospettiva futura ancora più rosea. Il loro stesso sistema politico, fondato sul debito dell’avversario, li ha inghiottiti in un marasma vorticoso, il consumismo, dal quale essi stessi non possono scampare. Pensate davvero sia stato un motivo umanitario a determinare il loro intervento – io che infierivo sul mio popolo! – o piuttosto non ricordate Saddam Hussein, accusato di possedere armi nucleari? Ma quale pensate sia l’obiettivo degli Stati Uniti e dei suoi vassalli se non quello di detenere e rendere omologabile, in senso totalitario, il dominio politico ed economico del pianeta? Non sono forse loro a scatenare a puntate l’attuale terza guerra mondiale in atto? Essi necessitano solo di soddisfare la fame del mostro che hanno creato, e conflitti e divisioni sono gli unici mezzi utili alla bisogna. Ora che ho ben chiara la situazione all’esterno del condotto dove mi sono svegliato ferito, non è certo la paura di morire a dominare i miei sentimenti. Il pensiero della fine mi ha sempre accompagnato destandomi sensazioni molteplici, ma nemmeno in un contesto così arduo mi riesce di pensare a lei come la soluzione più virtuosa di ogni mia preoccupazione. In nessun caso ho tentato di avvicinarla così come mai ho desiderato allontanarla. Accantonato il mistero che rappresenta per chi ne prova paura, o l’equivoco per chi la usa in modo violento aspettandosi una riconoscenza divina, la sua percezione mi è sempre servita e mi conforta tuttora per riflettere sulla valenza del suo significato rispetto alla vita stessa. E la morte non potrà mai considerarsi degna di tale nome, se un giorno non si prende atto di come il pur mediocre progetto inseguito in questo mondo sia stato in linea, o quanto meno prossimo, alle misericordiose aspettative dell’Essere supremo. Fatta questa considerazione, trovo ridicolo e insopportabile che sia un meschino brivido di freddo a infastidirmi alle prime luci del nuovo giorno e davanti allo scintillio delle armi imbracciate da loschi individui ormai neipressi del mio rifugio. A parte la teppaglia di tunisini, qatarioti, sudanesi e sauditi infiltrati, dei quali temo anche le sevizie fisiche, li riconosco quasi tutti, i miei ingenui connazionali; potrei chiamarli per nome e rivolgermi a loro con il lungo, tradizionale saluto libico, ricordando i loro padri, i nonni e finanche qualche bisnonno. Non si accorgono di essere usati come comparse su uno scenario pronto a tramutarsi in un incubo per le loro coscienze e per quelle delle generazioni a venire. Adesso, catturato e oltraggiato da mani e urla straniere, da dialetti irriconoscibili che non appartengono a nessuna delle dolci cadenze libiche, potrei raccontare loro di come erano abituati i nostri predecessori meno di quattro generazioni fa e dei progressi ottenuti resisten- do all’effimero e tragico progresso imposto in ogni parte del mondo, escluse poche eccezioni. Potrei citare la sconfitta dell’analfabetismo, dilagante fino al 1969, a dispetto dell’ignoranza che li spinge a tanto; o il mantenimento dell’identità e della sovranità nazionale rispetto al servizio a cui si stanno prestando, e anche il moderato ed equo benessere generale in opposizione alla crisi economica che dopo avere attanagliato le grandi potenze si è deciso di scaricarla qui, sui più deboli, anche con questo atto di forza che è la guerra nei nostri confronti. Ma potrei ricordare a questi miei assalitori non solo l’assenza di disoccupazione ma anche l’arrivo dei nostri fratelli subsahariani per svolgere mestieri da noi considerati, a torto, meno decorosi; la gratuità dell’istruzione e del pur insoddisfacente servizio sanitario; il diritto alla prima casa e la rivalutazione della figura femminile in una società pur non completamente libera a causa dei miei limiti e di debolezze intrinseche. Ma ora basta con il rivangare i successi, è sintomo di stanchezza. Anche se inferiori per numero, le sconfitte non lo sono certo per l’importanza che rivestono ai miei occhi. L’incapacità di fidarmi fino in fondo anche dei migliori collaboratori potrebbe racchiuderle tutte. Nella maturità, come del resto da giovane, la mia inadeguatezza caratteriale alla sintesi tra il rigore e la dolcezza nel rapporto con gli altri si è esasperata a danno di quest’ultima: a troppi pochi sudditi ho concesso l’esonero dal rispetto a me dovuto, non sempre indispensabile. A volte per errore mi sono sentito più vicino a Dio di quanto non lo fossi realmente. Quando manifestazioni pubbliche, amicizie conclamate o semplici cittadini mi tributavano riguardi simili a liturgie e lontani da umane e confidenziali dolcezze, non ho mai chiesto loro di passare a registri più umili e neppure di volermi soltanto bene. A volte il mio cuore ha nascosto anche con leali compagni di lavoro quelle remissività che parevano debolezze da superare nello scontro con la perfidia degli avversari. Quegli stessi avversari con cui adesso ho brutalmente a che fare. Ma forse la peggiore delle sconfitte è la consapevolezza che rifarei tutto come ho fatto: non ottusa ostinazione vi assicuro, ma devo ammettere con estrema semplicità di prvare tuttora una diffidenza assoluta di fronte alla provata inaffidabilità dei miei consimili. Questi limiti reciproci mi hanno sempre sconcertato tanto che ora mi rimbomba nelle orecchie la mia voce lontana di molti anni addietro: «… così io amo le masse e le temo proprio come una incognita. Nel momento del giogo, di quanta devozione sono capaci! Hanno sostenuto Annibale, Pericle, Savonarola, Danton, Robespierre, Mussolini e quanta crudeltà hanno dimo- strato nel momento dell’ira…, ma anche nei momenti migliori sento sempre sul collo il fiato di queste folle che non sono clementi nemmeno con i loro liberatori; mi acclamano, e mentre mi applaudono sento che mi abbandonano, mi bruciano…»8. Ora non è più il
freddo all’interno del condotto a farmi tremare e nemmeno gli oltraggi e le
violenze subite dalla
marmaglia drogata che mi ha catturato;
piuttosto è
ricomparsa l’inquietudine assente dalle mie membra dall’epoca in cui
nacqui sotto le
bombe degli invasori di una terra unica: la mia Libia. Ma quegli
invasori sono
tornati e ancora una volta qualcuno di noi li ha aiutati. Da qualche
giorno
ero rientrato nei territori della tribù di cui sono nativo, mi hanno
raccontato
di chi non mi ha mai rinnegato fino alla fine e di chi è stato abile a
cambiare casacca
all’ultimo. Me
lo hanno rivelato senza angosce, e per
rispetto della
mia situazione non lasciavano trapelare nulla nemmeno sulla gravità della
loro: sapevano bene che, una volta
rianimato il gretto odio tribale, se fossi caduto,
li
avrebbero perseguitati per la loro fedeltà.
8 Fuga all’inferno e altre storie, Roma, Manifestolibri, 2006, p. 51 e 53. |
||||||
| Ernandes homepage | vai su | Sammartano indice |




